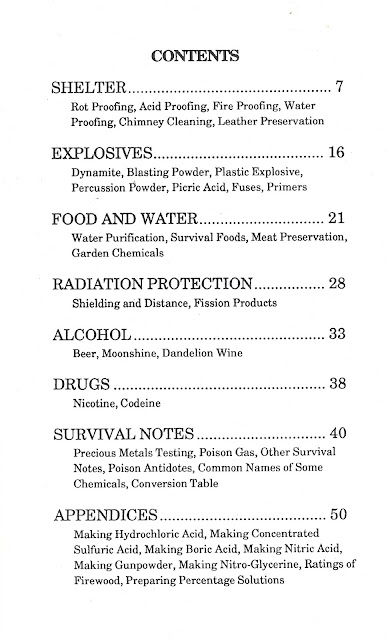categoria: pronto soccorso
Shock, tipi e fisiopatologia
Shock
Si definisce lo shock come una
situazione circolatoria anomala che porta a riduzione globale della
perfusione tissutale e che sfocia in alterazioni del funzionamento
degli organi vitali fino alla loro compromissione totale ed
irreversibile.
Tipi
di shock ed eziologia
Nel traumatizzato si possono
riscontrare contemporaneamente tutti i seguenti tipi di shock:
1) Insufficienza cardiaca (shock
cardiogeno), una insufficienza di pompa che può avere molte cause
tra cui la contusione cardiaca, l'infarto miocardico, l'insufficienza
cardiaca congestizia, il tamponamento cardiaco, lo pneumotorace
iperteso, l'anafilassi, la scarica elettrica ad elevato voltaggio e
l'avvelenamento.
2) Riduzione del volume circolante
(shock ipovolemico) provocato da emorragia sia interna che esterna o
perdita di liquidi ed elettroliti provocata da vomito e diarrea, da
insufficienza surrenalica acuta, da iperglicemia, da embolia
polmonare o da strozzamento intestinale.
3) Danni al letto capillare da
perdita di liquido plasmatico e di elettroliti in situazioni quali le
ustioni termiche, le lesioni da freddo, l'anafilassi, lo shock
endotossico (da tossine batteriche come, ad esempio, quelle della
cancrena gassosa) e le lesioni da schiacciamento.
4) Aumento della capacità
circolatoria (shock neurogeno). È provocata dalla dilatazione del
letto vascolare per perdita del controllo vasomotorio a seguito di
lesione del midollo spinale.
La descrizione che segue si applica
principalmente allo shock ipovolemico.
Fisiopatologia
Quando la gettata cardiaca si
riduce, diminuiscono anche la perfusione dei barorecettori carotidei
nel seno carotideo e la stimolazione del centro cardioinibitore nel
midollo allungato, per cui la frequenza cardiaca aumenta. Il centro
vasomotorio midollare risponde alla diminuzione della gettata con una vasocostrizione delle arteriole cutanee, splacniche e
muscolari e una vasodilatazione delle arteriole cardiache e cerebrali.
All'inizio, il polso (la cui pressione è uguale a quella della
pressione sistolica meno quella diastolica) si fa piccolo, mantenendo
per un certo periodo stabile la pressione ematica che,
successivamente, crolla. L'intensa vasocostrizione periferica porta
ad anossia stagnante e a cianosi periferica da eccessiva riduzione
della emoglobina (se presente in circolo in quantità superiore a 5
g/100 ml).
L'anossia stagnante fa sì che
l'ossigeno non giunga agli organi bersaglio e che si accumuli
anidride carbonica. I processi metabolici passano da aerobi ad
anaerobi, con accumulo di acido lattico e acidosi metabolica. I
chemorecettori carotidei nel corpo carotideo sono sensibili a questo
tipo di acidosi e stimolano il centro respiratorio, provocando un
incremento della frequenza respiratoria. La vasocostrizione
arteriolare periferica comporta riduzione della pressione idrostatica
all'estremo arteriolare del capillare, con netto riassorbimento di
liquido interstiziale ed elettroliti (a patto che la pressione
osmotica resti stabile) all'interno dei capillari e nello spazio
intravascolare.
L’organismo del soggetto ferito
risponde all’emorragia sostituendo al più presto le proteine del
plasma e gli eritrociti persi.